Tradire noi stessi
Ricorderete il nome del pianeta di origine di Superman. Krypton. In realtà questo nome esiste davvero, e si riferisce a un elemento chimico, il kripton (o kripto o cripto), che è una parola derivante dal greco: κρυπτόν, kryptón: “nascosto”. Il kripton (Kr) è un gas nobile incolore, inodore e insapore che si trova in piccole quantità nell’atmosfera. Sin dalla sua scoperta – ad opera di William Ramsay e Morris Travers nel 1898 - è stato considerato “nascosto”, perché in origine fu difficile da rilevare e isolare.
Esiste un elemento “nascosto” anche nella nostra chimica affettiva. Ve ne è una traccia in ciascuno di noi. Come il kripton, anche se sembra invisibile, nascosto, ha una sua ragione d’essere, non è lì per caso; in qualche modo deve far parte dell’“atmosfera” della nostra esistenza: è il tradimento; più precisamente, il tradimento di noi stessi. Tradire noi stessi – in una certa, variabile misura – è inevitabile. E ha luogo sin dalle prime fasi della nostra esistenza.
In che consiste questo tradimento?
Cresciamo in un ambiente fatto di relazioni, prima fra tutte quella con i nostri genitori. Queste relazioni sono sin dall’inizio il materiale grezzo che andrà a costituire la nostra mente, la nostra personalità. Su questo aspetto – le relazioni come materia prima costitutiva della mente – avrò modo di ritornare spesso. Ciò su cui voglio focalizzarmi qui è che l’insieme di queste relazioni – che da ora chiamo “ambiente relazionale” - sin dalle fasi più precoci del nostro sviluppo personale, ci insegna cosa dobbiamo essere, ma anche cosa non possiamo permetterci di essere. Questo è dovuto - come scrive Paul Wachtel, un autore a me molto caro - «all’inevitabile selettività dell’amore e dell’attenzione di chi si prende cura di noi». E noi siamo molto molto sensibili a quella selettività. Alcuni comportamenti e caratteristiche che si manifestano mentre cresciamo vengono “preferiti” o rifiutati dall’ambiente relazionale. Quali comportamenti e quali caratteristiche vengono preferiti e quali rifiutati? La risposta varia in base alle “regola di funzionamento” dell’ambiente relazionale in cui cresciamo. In un dato ambiente, la nostra attitudine al gioco e alla gioia spensierata può essere accolta con freddezza o franca riprovazione; mentre la nostra scrupolosità e riservatezza può essere accolta con segnali di affetto e approvazione. In un altro ambiente, qualità basate sulla prestazione, come essere sempre “il più bravo” o “il più bello”, possono generare una reazione molto favorevole nell’ambiente; mentre mostarsi generosi e cooperativi può essere bollato come “roba da deboli”. O ancora, in un altro ambiente impegnarsi per raggiungere obiettivi personali può essere considerato “egoistico” o “inutile”; mentre sacrificarsi per gli altri membri della famiglia rinunciando al desiderio di essere visti, e/o alla propria realizzazione personale è considerato un valore imprescindibile.
Ogni ambiente funziona secondo le proprie regole, che determinano cosa di noi sarà accettato e amato, e cosa sarà più o meno esplicitamente – a volte molto sottilmente - disapprovato e rifiutato. Ma la selettività in sé, la preferenza dell’ambiente per certi modi in cui sin da piccoli ci comportiamo, sentiamo, sperimentiamo il mondo, è inevitabile e universale. È come se l’ambiente, senza poterne fare a meno e in modo quasi sempre del tutto automatico e inconsapevole, ci comunicasse silenziosamente, nel tempo, che alcune parti di noi hanno il diritto di vivere, mentre altre devono essere necessariamente scartate; e se questo non accade, l’ambiente sarà insoddisfatto. La nostra mente, nella delicatezza del suo processo di sviluppo, deve necessariamente semplificare; non ha strumenti per comprendere e mettere in discussione questa richiesta. Dovrà adattarsi, perché avvertirà che se non si adatta, rendendo quindi insoddisfatto l’ambiente, perderà il legame affettivo con quell’ambiente. Un bambino che vede lo sguardo soddisfatto e amorevole dei genitori solo quando è “il più bravo di tutti”, ma perde quello sguardo quando gioca e si sporca nel fango, o quando è triste e bisognoso di comprensione, crescerà sentendo che l’unico modo per mantenere quello sguardo su di lui è continuare a sforzarsi a essere il più bravo di tutti. E non smetterà di adeguarsi a questo principio crescendo. Avvertirà la necessità di essere il più bravo di tutti anche quando sforzarsi di essere il più bravo di tutti è del tutto fuori contesto; per esempio nell'intimità amorosa.
Ecco, quindi, l’inevitabile, inconsapevole, tragico auto-tradimento che mettiamo in atto sin dalle prime fasi della nostra esistenza per adattarci alla richiesta dell’ambiente: la scultura progressiva di un'identità - di un modo di posizionarci nel rapporto con noi stessi e con gli altri - basato su due parametri: 1) lo sviluppo di una versione di noi stessi che gratifica l’ambiente relazionale; 2) l’eliminazione di parti importanti di noi tendenzialmente sgradevoli per quell’ambiente.
Nel corso delle prossime puntate vedremo quali conseguenze questo tradimento genera; e che cosa significa “eliminare” parti importanti di noi stessi.
Ma ci sarà anche spazio anche
per gettare uno sguardo sui possibili rimedi a questo auto-tradimento.



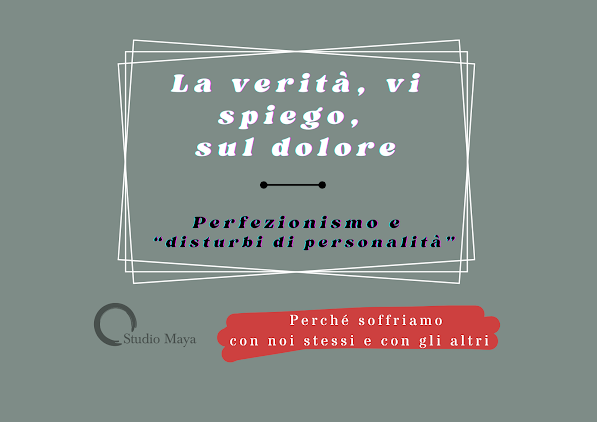.png)
Dottore, buonasera.
RispondiEliminaL'auto-tradimento, o auto-inganno come definito nell'articolo precedente, è sicuramente figlio del processo di costruzione emotiva di ognuno ma, nostro malgrado, getta le basi in una fase della nostra vita di assoluta inconsapevolezza.
Quindi lo subiamo passivamente e ci portiamo dentro gli effetti senza essere capaci di individuarne le cause.
La scultura progressiva di un'identità, definizione che mi piace molto, si realizza con scalpelli che noi non controlliamo e, una volta terminata, se mai termina, ci restituisce un'immagine che noi crediamo nostra.
Quindi io mi chiedo e Le chiedo: chi e come ci può far capire che quella piega che vediamo guardandoci allo specchio va nel verso sbagliato?
Cosa ci può istillare il dubbio che quella forma non ci appartenga?
Dobbiamo necessariamente pagare il prezzo di sbagli non nostri?
E, poi mi fermo per non tediare oltre, in quale cassetta degli attrezzi possiamo trovare gli utensili per 'aggiustarci'?
Come sempre, La ringrazio.
Giovanni Torre
Caro Giovanni, in una certa misura la "scultura" va sempre nel verso sbagliato; nel senso che ci impedisce di essere in contatto con parti vitali e pulsanti di noi stessi, come diceva anche Rogers. Possiamo recuperare tale contatto con un percorso di esplorazione, per esempio una buona psicoterapia, in cui però il terapeuta per primo sia stato e sia costantemente aiutato a far luce sulle parti di sé dissociate. Avrò modo di tornare su questo. Grazie per la sua sentita partecipazione. A presto
RispondiElimina